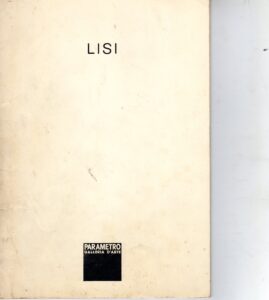Dopo esordi assai brillanti nell’ambito della «nuova figurazione» (ma si trattava d’una figuratività allucinata, di «apparizioni» di oggetti o corpi o particolari di figure in atmosfere tutt’altro che realistiche, in una luce rossastra ed estraniante, medianica) Bruno Lisi ha lavorato per anni senza esporre, senza cercare contatti col pubblico, tenendo però un rapporto vivo e dialettico con amici artisti e critici e quindi con la cultura attiva. Sono stati anni di raccoglimento e di meditazione, più che di isolamento, durante i quali Lisi ha maturato, traverso una serie di passaggi graduali, una propria arte non figurativa originale e intensa: la quale non contraddice alle premesse iniziali, nonostante le trasformi radicalmente con la rinunzia alla figuratività, almeno in quanto salva la vecchia idea della forma (oggi, come vedremo, della luce) quale «apparizione» che condiziona, determina e crea lo spazio in cui si propone, piuttosto che quale oggetto aprioristicamente dato in uno spazio già costruito, e che deve essere soltanto messo a fuoco mediante una serie più o meno complessa e sottile di relazioni.
La pittura attuale di Lisi si serve di una iconografia estremamente limitata e severa: uno o più fasci di luce verticali che si restringono a cuneo al centro del quadro. partendo dal suo margine superiore e che toccano, coi vertici, altrettanti identici fasci di luce provenienti dalla base del quadro stesso. Questo schema semplicissimo sopporta, è ovvio, un gran numero di varianti:, apparentemente minime (dato che tutto ciò che può cambiare è il numero dei fasci luminosi, la loro grandezza, il loro colore e quello dello spazio in cui appaiono, la loro collocazione eccetera) ma in realtà di gran rilievo in un lavoro tutto acutamente calcolato e svolto ai limiti dell’effabilità. Lisi opera quindi esclusivamente col colore-luce: ma la luce si rivela nel colore (né potrebbe essere altrimenti) senza giocare sul colore, o meglio sugli accostamenti, sulle consonanze e dissonanze cromatiche. La luce è colore che appare, o irrompe, in un non-colore e, col suo apparire, determina degli accadimenti spaziali: nient’altro.
La luce cioè, come prima ho detto, connota uno spazio. Uno spazio che per non essere precostituito, per non essere né reale né mentale, «diviene» in ogni quadro in maniera diversa e con sempre diverse potenzialità e possibilità. Si tratta quindi di allusioni spaziali fortemente ambigue, continuamente reversibili, interpretabili (a seconda del punto di vista, della luce ambientale o magari delle condizioni soggettive di chi guarda) ora in questo e ora in quel modo. I piani d’ambiguità su cui lavora Lisi sono di almeno tre tipi, ad essere precisi. I coni di luce provenienti dall’alto incontrano i coni di luce sorgenti dal basso, il che evoca un effetto (in realtà inesistente) dì riflessione speculare: ecco una prima ambiguità. Il «positivo» dei coni luminosi isola nello spazio un «negativo» che lo bilancia fermamente, sicché talvolta prevale il primo e talvolta il secondo: ecco un’altra ambiguità. I vertici degli opposti coni luminosi, toccandosi, creano un’illusione di «punto di fuga», un’ipotesi prospettica, designando quasi un piano orizzontale: ecco una terza ambiguità. Ambiguità, si badi bene, non meramente «ottiche» (nulla Lisi ha a che fare con l’optical art) ma semmai psicologiche, nel senso che insinuano in chi guarda una sorta di malaise spazio-temporale che molto translatamente ha qualcosa a che fare col dépaysement surrealista.
La pittura di Lisi è difficilmente «etichettabile» e assai male riconducibile a questa o a quella tendenza di moda, sia pure la cosiddetta «nuova pittura» che è diventata dilatabile al massimo e onnicomprensiva. Direi che anche per questa ragione essa va guardata con molto interesse, frutto, come è, di una personalità orgogliosa di procedere per proprio conto.
(testo scritto in occasione della mostra alla galleria “Parametro”, Roma, 22 gennaio-21 febbraio 1976)